Di Sergio Leoni, dottore in Lettere, del Movimento per la Rinascita Comunista
Che la poesia trovi la sua massima espressione nella lettura a voce alta è soltanto una delle tante affermazioni che si riducono troppo spesso a mere petizioni di principio che quasi mai si traducono in fatti concreti. Lettura ad alta voce che, naturalmente, non va intesa come “declamazione” più o meno enfatica, ma piuttosto come narrazione (oggi il termine è completamente inflazionato, travisato e per lo più usato a sproposito) che si sviluppi secondo canoni codificati, se pur continuamente modificabili nel tempo, nel corso dei secoli e di pari passo con i rivolgimenti, le stagnazioni, le crisi in genere in cui il fare poesia si materializza.
Una narrazione di questo tipo presuppone, necessariamente, di almeno “un” ascoltatore. E non per nulla la figura dell’attore, e dunque in qualche modo quella del poeta che in solitudine e magari davanti ad uno specchio recita Shakespeare, appartiene forse al genere del grottesco ma certamente è l’immagine più concreta del patetico.
L’“ascoltatore”, figura ancora dai contorni imprecisi, fa comunque presto, e talora indipendentemente dalla propria volontà, a diventare un vero interlocutore, non più cioè figura passiva che recepisce semplicemente un testo, ma che quel testo rielabora in se stesso in un “gioco” che, seppure non espresso apertamente, è comunque destinato a coinvolgere nuovamente e in prima persona l’Autore.
In una intervista alla radio di qualche anno fa rilasciata poco tempo prima della sua morte, Ezio Raimondi, uno dei più grandi critici letterari del secondo dopoguerra, rispondeva a quella che era in qualche modo una domanda obbligatoria e di rito (su quanto avesse cioè avuto e dato dalla frequentazione e dal confronto con i suoi studenti), affermando in maniera per certi versi sorprendente (uscendo cioè dall’immagine consueta del barone universitario) ma estremamente convincente che, senza quegli scambi, più o meno serrati, più o meno polemici, non sarebbero potuto nascere quei suoi testi che, oggi lo vediamo con definitiva certezza, sono stati e sono altrettante pietre miliari nella storia della critica letteraria, non soltanto in ambito italiano.
Senza enfasi, e senza voler ridurre il nocciolo della poesia ad uno scambio di “sensi” i cui contorni, in questo caso, sarebbero tanto indefiniti quanto aleatori e che ci farebbero tornare in qualche modo alla più deleteria atmosfera di un romanticismo mal digerito, e frequentato come quasi sempre accade dai più scadenti epigoni, occorre ammettere che anche in poesia (si potrebbe anche dire “particolarmente” in poesia) si verifica quello che più che definire uno scambio potrebbe allora essere più convenientemente definito come il “momento” di una dialettica in cui la figura del poeta si definisce per un ruolo concreto, efficace: quello di saper suscitare temi, questioni presenti nella società, espressi o meno, latenti o potenziali.
È in riferimento in particolare a questa ultima questione, questione comunque ancora aperta e passibile di tanti sviluppi, che sono tornato a rileggere, dopo una prima lettura forse meno attenta, il testo di “La mia poesia”, uno dei brani che contribuiscono a definire la struttura coerente della raccolta “La rivolta dei demoni ballerini” di Antonio Catalfamo, edito nel 2021 dalla casa editrice Pendragon.
Vale la pena di riportare questo testo nella sua completezza e in tutta la sua “lunghezza” che è inusuale nella produzione poetica contemporanea, ma lo è anche rispetto alle altre poesia presenti in questa raccolta. Certo la lunghezza non può essere considerata “in sé” un criterio di giudizio, ma non può nemmeno essere derubricato a mero aspetto tecnico. Con un paragone che riprendiamo dalla musica classica, classica se non altro perché ormai è stata analizzata sotto ogni aspetto, in tutte le sue forme e in tutte le sue strutture più o meno nascoste: il fatto che una sinfonia di Beethoven (per citare un autore che nessuno può ignorare) sia “in Do”, come si dice in linguaggio musicale e poi sia divisa in movimenti che hanno ognuno una sua caratteristica ben determinata, testimonia da un lato della volontà precisa dell’autore di fare quella scelta e solo quella, sapendo però, e qui sta il nocciolo della questione, che facendo quella scelta deve per forza “adattarsi” a canoni non così precisi o inamovibili come si potrebbe credere (diversamente la musica non cambierebbe mai), ma adattarsi comunque sì.
Non diversamente la stessa cosa avviene in ambito poetico, che l’autore ne sia o meno consapevole.
E magari si potrebbe dire, non senza una punta di malizia, che il poeta che non conosce quello che definirei approssimativamente il recinto in cui muoversi, rischia di uscirne, ma solo nei termini di una fuga in avanti senza esiti possibili. Niente, è stato scritto, assomiglia così tanto allo status quo quanto una falsa rivoluzione.
Ma leggiamo:
“La mia poesia”
Mio nonno tornò dalla guerra
senza camicia:
dovette darla in pagamento
al barcaiolo
per farsi traghettare.
Mia nonna lo immerse
in una bagnarola
d’acqua bollente
per liberarlo dai pidocchi.
Tutto ricominciò da zero.
Poi misero la luce elettrica,
ma mio padre continuò studiare,
per anni, alla luce povera
del lume a petrolio.
La mattina andava a scuola, di corsa,
attraverso la scorciatoia di Vignale,
arrivava trafelato,
prima che il bidello suonasse,
inesorabile, la campana,
e chiudesse il portone,
alle otto e mezzo in punto.
Al ritorno sul camion
di Carmine Bovaro,
residuato bellico,
lento come un manzo,
gli studenti appesi a grappoli
agli sportelli.
I professori di ginnasio
ripetevano in eterno
le stesse cose con le stesse parole,
esercitavano, con sadismo,
il diritto di vita e di morte,
la campana del convento scandiva
il lavoro degli uomini.
La poesia mi serve
a raccontare
la vita degli umili,
a dire sgrì,
come Santo Calì,
a dire mmè,
a usare il linguaggio universale
di uomini, piante, animali,
a ritornare al ‘naturale’ di Ruzante.
Non mi interessano i versi barocchi
del poeta-puttaniere
che ruba amore mercenario
nella città dello Stretto,
dominata dalla follia,
dal tanfo di salamoia
nei barili del porto.
Il poeta-renitente manda al fronte
i contadini, e lui, agrario parassita,
consacrato all’arte,
ingravida le mogli.
Il poeta esoterico compra
pasta di seconda per i gatti,
difende il suo feudo
contro gli scioperi a rovescio.
L’eterno feudalesimo
della Sicilia:
sopra, i padroni di terre,
con i magazzini pieni di vino, olio,
formaggio gonfio, panie di fichi secchi,
pomodori invernali e agli
intrecciati a ghirlanda.
Sotto, i contadini, che prendono
la decima nel riparto dei prodotti,
gli artigiani, pagati a ‘merito’
con una bottiglia di vino.
Eppoi un esercito di questuanti,
clientes, famigli, ruffiani, servi.
Il critico strutturalista,
fascista paludato,
mesce liquami di fogna,
esalta la belle èpoque
e i figli di sgarro.”
Credo che fin dai primi versi appaiono evidenti quegli elementi di cui ho dato qualche cenno e che si riassumono, in qualche modo, nella possibile definizione di poesia colloquiale, di poesia in cui davvero il poeta è il narratore, il moderno aedo di una odissea umana che, per non riguardare grandi eroi ma gli uomini e l’umanità di tutti i giorni, non è meno efficace e soprattutto meno “alta” in termini di ispirazione. L’Autore “parla” e il suo discorso è insieme racconto di un mondo vissuto e scelta di parte “contro” l’altra parte della società, quella che detiene un dominio non solo economico, e che occorre smettere di considerare “naturale”, e tanto meno immodificabile.
“Giustizia”, “La malora” si muovono sulla stessa falsariga. I versi sono brevi. Le affermazioni di cui si compongono non ammettono repliche e si costituiscono come dati di fatto. La realtà, soprattutto quella più cruda, va raccontata per quello che è.
“La rivolta dei demoni ballerini”, che dà anche il titolo alla raccolta, ci offre dal canto suo una doppia opportunità.
Da un lato conferma nella sostanza quello che si è già detto per gli altri titoli. Catalfamo, collocando questa poesia a ridosso delle ultime che chiudono la raccolta, sembra voler riaffermare i temi già enunciati lungo tutta la raccolta, compiendo una sorta di chiusura del cerchio. Quello che in musica (le analogie tra queste due forme d’arte mi pare possano essere date per acquisite, a partire dalla constatazione che le due arti praticamente coincidevano qualcosa come duemila anni fa) è rappresentato dalla ripresa del tema iniziale, o di un tema che comunque sia fortemente rappresentativo dell’opera. (Un buon esempio è rappresentato dalla chiusura della Turandot, opera che Puccini non poté terminare e che venne “completata” da Franco Alfano che riprese, quasi nota per nota, l’aria più importante dell’opera: ‘Nessun dorma’).
Qui, infatti, il “tono” (un vocabolo più preciso è quasi impossibile da trovare) torna al registro “narrativo”. Di più, vira verso una sorta di cronaca in poesia. Il cantastorie, che evidentemente, in versione moderna, è una parte dello stile di Catalfamo, si riaffaccia tra le righe.
“Mio padre, per primo,
si staccò dal corteo
e dal coro dionisiaco,
e cantò per i posteri
la tragedia neogreca,
battuta sui tasti
di una Olivetti 22.
Io, dopo di lui,
prolungo il canto,
nella società digitale
iperconnessa,
perché i giovani ascoltino
e imparino”
Una sorta di grado zero di scrittura applicato alla poesia? Un rifiuto completo del “fare poesia” secondo i canoni tradizionali?
Niente di tutto questo, a ben vedere.
Piuttosto, suggerirei, una scelta insieme programmatica e di stile.
Ma è proprio questa poesia, cui l’Autore dà evidentemente un significato particolare al punto da farne il titolo della raccolta, a farci da tramite all’altro grande tema che in questo libro costituisce l’altro “polo” su cui occorre focalizzare l’attenzione per non lasciarsi sfuggire una parte non solo importante ma essenziale nella disanima di questo libro.
Waafa A.Raouf El Beih scrive una prefazione ricca di notizie sulla vita di Antonio Catalfamo. Ma sottolinea opportunamente:
“La presente raccolta contiene la versione più aggiornata della poetica del mito, così come è stata elaborata da Catalfamo a conclusione di un lungo percorso letterario. Il poeta si richiama al concetto di ‘biogeografia culturale’, in base al quale il territorio non costituisce solo un’area geografica. In esso si stratificano tutte le civiltà che si sono succedute nel corso dei secoli, anzi dei millenni, con i valori e i sentimenti che ad esse hanno dato vita. Anche il poeta, se è profondamente legato a quel territorio, assomma in sé quelle civiltà, per cui si viene a creare una ‘corrispondenza biunivoca’ tra lui e il territorio di riferimento. Egli riesce a ‘decriptare’ i messaggi ‘cifrati’ che vengono da questo territorio e a tradurli in versi”.
E più avanti:
“Così nei versi di Catalfamo riemerge tutto il mondo greco dal quale egli proviene”.
Esempi evidenti di questo atteggiamento verso le proprie radici, si trovano sparsi lungo tutta la raccolta. Cito solo un paio di titoli e qualche verso che sembrano essere significativi in questo senso: “Simbologia della vigna” (“Mio padre/ appollaiato su un albero/ studiava i classici, penetrava nel mito greco. / Come Scotellaro/entrava nella vigna, / che ci fa discendere / all’Ade, ci mette in contatto con gli antenati/…”), e “Antenati”: (‘Gli spazzini della storia, /eterni questuanti, / raccattano nei secoli/ riti pagani, /li rivestono d’abiti cristiani, /in cambio di un’offa/…’).
Si comincia a capire adesso, o per lo meno i contorni delle questioni in campo si fanno più precisi, quali siano i due gradi piani in cui si muove la poesia di Catalfamo: in uno si realizza il recupero in chiave di attualità del mondo atavico, nell’altro l’altro la poetica si fa ragionamento, lucida deduzione dai fatti concretissimi della vita reale, della vita sociale. Questi due piani finiscono poi per intrecciarsi inestricabilmente e uno vale a rafforzare l’altro e viceversa.
Laddove invece sembra non realizzarsi questa specie di fusione, e penso alle due poesie che, curiosamente, aprono la raccolta, “Microcosmo” e “Dionisio e noi”, il tono, mi pare, tende ad un lirismo che, se pur tecnicamente riuscito, conserva un’enfasi cui è difficile dare un significato e un ruolo. Curiosamente, dicevo, perché, immediatamente dopo questo inizio che farebbe pensare ad una raccolta di poesie tutte giocate su un registro dai toni del genere unione quasi mistica tra una natura primordiale e un corpo che di umano ha troppo e insieme troppo poco (‘…/ Il tuo sesso esplode,/ erutta lava,/ come il cratere di un vulcano.’), si passa poi, senza soluzione di continuità, in una sorta di immersione totale nella realtà, e per di più non in quella di tutti i giorni, ma in quella più drammatica: “Giustizia” : “ Un compagno è morto/impiccato./ L’amianto ha ucciso i padri, / scheletriti,/ ogni giorno più piccoli/ nel loro letto-sepolcro,/ senza la Giustizia, / che dorme tranquilla,/ in pigiama,/ nei palazzi ovattati del potere/……”.
Difficile pensare che l’Autore non abbia scelto con esattezza quale ordine dare alle poesie nell’ambito della raccolta. Né è possibile credere che egli per primo non si sia reso conto di quale grande “stacco” ha creato impostando un’impaginazione di questo tipo. E le impaginazioni, l’ordine con cui si sistemano i tasselli che fanno l’opera nel suo insieme, contano qualcosa. Non resta dunque che pensare che ci sia stata piena consapevolezza in questa scelta così particolare.
Non vorrei d’altra parte dare troppa importanza a quello che, dopo tutto, non è che una scelta di una “scaletta” (ci risiamo con la musica), discutibile magari ma che in fondo è poca cosa rispetto ad un impianto generale ben costruito. Se lo sottolineo non è certo per muovere una critica ad Antonio Catalfamo, ma, al contrario, per segnalare il coraggio che egli ha mostrato nel contaminare, o almeno ad accostare tematiche in apparenza lontane ma che, andando avanti nella lettura, così lontane appaiono poi sempre meno.
Certo, il tema del recupero delle radici è particolarmente scottante. Non lo è da oggi, non lo ha inventato la cultura dominante che ci avvolge come in una cupola sotto cui, per dirla con Asimov (Cronache della Galassia), si possono formare anche le nuvole.
Ma sicuramente la cultura dominante si è appropriata di questo tema in una maniera talmente vistosa e insistita da far pensare che ad esso venga affidato, neanche tanto nascostamente, un preciso ruolo.
Il richiamo alle origini, la “narrazione”, questa sì, ancora una volta, del tutto fasulla, di un passato che giustificherebbe il presente ( e, va da sé, tutte le nequizie che esso propina), il costanti rifarsi ad un tempo quasi mai precisabile, sempre un po’ indefinito, appare come il tentativo, maldestro ma efficace in tanto quanto sempre meno soggetti sono disposti a smascherarlo, di dare una patente di credibilità, di prestigio che sarebbe dovuto, e qui sta tutta la rozzezza e la stupidità di fondo di questo meccanismo, fondamentalmente al fatto di esistere da tanto tempo.
Una controprova? Non c’è oggi attività commerciale al minuto, quelle cioè non solo minacciate ma concretamente in odore di sparizione per mano della GDO, grande distribuzione organizzata, che non cerchi di darsi una parvenza di “storicità”, di lanciare il messaggio: “siamo esperti, siamo nel settore da tanto tempo”. Tentativo maldestro di recuperare una clientela persa che tocca il ridicolo quando sulle insegne appare la scritta: “since (sic) 2010”.
La domanda più che legittima, a questo punto, dovrebbe essere la seguente: ha ancora una sua utilità richiamarsi ad un tema che la cultura dominante ha già accolto, assimilato e svuotato di ogni senso, come del resto fa per ogni espressione artistica, culturale.
Nel dominio del capitale la cultura ha solo la funzione di una enorme distrazione di massa. Lo sappiamo (dovremmo saperlo) a partire dalla critica radicale della Scuola di Francoforte, passando per la controversa ma profonda critica radicale dell’Internazione situazionista cui si deve, fatti salvi giganteschi limiti ideologici, se non altro, l’idea di “società dello spettacolo”; anche questa fagocitata e digerita dalla cultura dominante.
Ma un poeta che scrive, fa parte allora di questo grande inganno?
Domanda inquietante a cui si può provare a rispondere con la pubblicazione di libri come questo, sapendo che sono briciole di fronte allo strapotere di una sedicente cultura mainstream. Ma a volte le briciole, come le pulci nelle orecchie, qualche domanda impertinente sono capaci di suscitare.
Questo rende il libro di Antonio Catalfamo, non fosse altro per quello sguardo obliquo e polemico che getta sul nostro tempo, sulla nostra società assolutamente prezioso.
Vorrei chiudere questa che non è, come sempre, una recensione ma un invito alla lettura con l’aggiunta di un paio di considerazioni.
Antonio Catalfamo non è privo di una vena giocosa, di quel modo di scherzare di Arlecchino, e di tutta la commedia dell’arte, che appunto ridendo diceva il vero: “Versetti semiseri”. Riportarla qui per intero occuperebbe troppo spazio. Andrebbe letta, in un’ottica in cui tutto ciò che è a disposizione dell’arte per criticare lo status quo deve essere usato, come un’altra opportunità. Nessuna opportunità dovrebbe essere sprecata.
Dalla postfazione: “Poi ci sono, per fortuna, poeti utili che preferiscono discutere i problemi del tempo in cui vivono. (…).
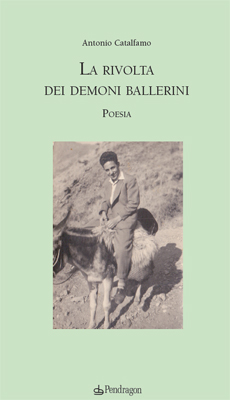
Lascia un commento